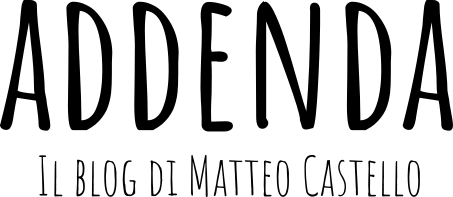Fuori sembra che il sole si stia mangiando tutto.
“Non mi era mai capitato.”
“Cosa non ti era mai capitato?”
“Di non riuscire a farti… Di non essere capace di. Insomma, hai capito.”
La luce che divora la stanza è appena smorzata dalle tende leggere, immobili nell'aria pesante. Non c’è un filo di vento, eppure un brivido mi percorre il corpo, scorrendo dalle unghie dei piedi al cuoio capelluto.
“Non sei tu, sono io che sono stanco. E ho altro per la testa” dico bofonchiando, consapevole che certe situazioni richiederebbero un rigido protocollo, non questa stentata improvvisazione.
“E a cosa pensi?”
Magari fosse così facile. Ho la sensazione di non avere niente in testa. Mi accendo una sigaretta nella speranza che l’attesa e il fumo smorzino l’imbarazzo che impregna l’aria del salotto.
“A volte non è facile sapere a cosa si sta pensando. Ho la testa sia piena che vuota. Come se i pensieri, sai, come se tutto quello che penso faccia da tappo”. Dico proprio così, suona piuttosto bene.
“Ho sbagliato qualcosa?”
Non ha attecchito.
“Ma no, che dici?”
“Non ti piaccio più?”
È convinta che sia colpa sua.
“Sei bellissima, lo sai”.
Non se la beve. Vorrei stare zitto ma tutti questi vuoti sono insopportabili.
“Guarda che non è colpa tua. Succede. Capita”.
“E quand'è che capita?!”
Butta fuori la voce scossa da un improvviso fremito, di botto, come se si fosse rotto l’incantesimo che la teneva invischiata nel torpore di poco prima. Non mi aspettavo tutta questa insistenza.
“Te l’ho detto, capita quando si ha la testa piena”.
“Ma cos'hai nella testa?”. Ora è arrabbiata. “Guarda che non sono mica stupida, non dirmi che non ti è venuto duro per caso. Sei un cazzo di fantasma, è chiaro che... che non mi ami più”.
Eccolo il famigerato punto della questione.
‘La verità è che non mi piaceva il tuo odore’. Vorrei dirglielo ma sarebbe brutale, oltre che ingiusto: anche io non sono un fiorellino dopo questa giornata lunga e caldissima. Come le è venuto in mente di farlo così all'improvviso, con tutta questa fretta? E poi perché proprio su questo divano che non mi appartiene?
La guardo: ha messo su il broncio da bambina che compare sempre quando litighiamo. D’un tratto la sua nudità mi appare come una minaccia, come una corazza frapposta tra le nostre intimità separate. Eppure è lei a sentirsi esposta, e infatti si rimette la maglietta senza badare a quale sia il verso giusto. Si rimette solo quella. Mi copro anche io, rialzando i pantaloni rimasti attorcigliati alle caviglie, e tutto pare così tragico e ridicolo che vorrei fare qualcosa - qualsiasi cosa - per smorzare la tensione.
Invece mi limito a guardare intorno con occhi stanchi mentre lei annaspa di fronte a me, lo sguardo fisso su un punto vuoto oltre il vaso di fiori sul tavolo del soggiorno. Le gambe incrociate lasciano trasparire un ciuffo scuro. Mi scappa un sorrisetto nervoso.
“Non c’è niente da ridere, sei proprio... cattivo”.
D’improvviso sento che ora potrei, ma è tardi. Dobbiamo uscire.
Il lampione davanti a casa proietta riflessi fosforescenti sulle cromature dell’auto. Non ci parliamo. Le faccio segno, sfiorandola, di aspettare che passi una macchina prima di attraversare. Fa uno sbuffo, si sporge oltre il marciapiede e l'automobilista rallenta appena, proseguendo la sua corsa. Lei tira dritto come niente fosse verso il posto del passeggero. È avvolta in un lungo vestito a fiori che lascia la pelle della schiena scoperta, aggrappandosi ai fianchi per poi scendere in caduta libera fino a un paio di sandali color sabbia. I capelli vaporosi ondeggiano sulle spalle, ingoiando la luce nel loro nero profondo. È bella, elegante, sensuale (mentre lo penso deglutisco: ora potrei). L’eleganza non è mai sembrata richiederle troppi sforzi, le viene naturale. Io invece sono un disastro. Mi sbottono il collo della camicia, fa ancora troppo caldo.
La macchina scorre nel traffico rado della sera. L’ambiente ovattato che si crea all'interno dell’abitacolo mi rilassa, l’aria condizionata diffonde un sentore di plastica nuova e pino silvestre. Lei è muta, il viso nascosto dai capelli, lo sguardo rivolto fuori dal finestrino in ostentata immobilità.
Un gatto attraversa la carreggiata all'improvviso, inchiodo e sbando, mentre la macchina dietro scarta sulla sinistra superandomi per non centrarmi in pieno, il tutto in un tripudio di clacson.
“Cazzo!”
Per un attimo è solo silenzio.
“È sempre così, sbucano fuori all'improvviso e non ci puoi fare niente”.
Mi stupisce riascoltare la sua voce.
“Almeno non l’ho messo sotto”.
“Sì, ma vediamo di arrivarci interi al Bristol”.
“Sai che voglia…”.
“Oggi con le voglie non ci vai forte”.
Mi pare l’abbia detto con un accenno di sarcasmo. Mi abbandono anche io ad uno sbuffo. “Colpito e affondato”. Le accarezzo la mano, me lo lascia fare.
Il Bristol è come al solito colmo. I camerieri fluttuano come ectoplasmi tra le luci soffuse, aggirandosi per i tavoli e lanciando cenni di intesa in risposta ad ogni sguardo bisognoso. Qualche strillo eccitato si solleva dalle portate e dalle bevande colorate, contrappuntando il vociare indistinto che ristagna nello spazio e il levare meccanico di un sottofondo musicale lounge. In posti come questo la socialità si concentra e articola intorno alle scelte del drink, alle tonalità dei colori portate alle labbra. Laura e Marco sono già lì, l’uno di fronte all'altra, cellulari alla mano. Soli. Sembrano ondeggiare come canne in una palude, irrorati dai toni bluastri e liquidi degli schermi accesi. È Laura a vederci per prima. Alza un braccio sfoggiando un sorrisetto di sincero sconcerto, come se non si aspettasse di trovarci insieme. “Eccovi finalmente, pensavamo foste scappati via!”.
Appena prendo posto Laura mi bacia con una certa ostentazione sulla bocca. Nello scostare le labbra dalle mie la sento indugiare, come se stesse cercando di trattenere qualcosa dai miei umori, dei miei segreti. Il suo profumo dolciastro si mescola all'alcool. Ha già bevuto.
“Grazie di essere andato a prenderla tu”, mi dice Marco. Poi si rivolge a lei, ancora imbronciata ma per motivi nuovi. “Scusa ancora se non sono passato io, ma non saremmo arrivati più questa sera, il traffico è una pazzia”. Tutto è superfluo ma serve per rimettere le cose al loro posto. Non è certo la prima volta che capita.
“Non ti preoccupare, meglio così, casa nostra è sulla strada”. Mi guarda. “Però il tuo amico stava per investire un gatto”, aggiunge mentre cerca una posizione comoda nella poltroncina di fronte. Marco le stringe un avambraccio per riaffermare un possesso sospeso. “L’importante è che non l’abbiate schiacciato”, fa lui già rivolto verso gli altri tavoli, distratto.
“Sì, ho detto la stessa cosa...”, risponde lei continuando a fissarmi.
Passiamo i seguenti minuti a ristabilire le reciproche appartenenze, io col braccio adagiato sullo schienale di Laura, Marco con le dita che accarezzano il polso di lei. Lei, che però si ritrae con una scusa, per capire cosa ordinare. La guardo, non riesco a staccarle gli occhi di dosso. “Tu cosa bevi?”, mi chiede Laura, e in quella domanda ce ne sono altre mille. Scopi con la nostra amica comune? Te lo ha succhiato bene prima di venire qui? Che senso ha stare insieme dopo tanti anni se non ti interessa che io sia qui con Marco ad aspettarti, mentre tutti pensano che siamo un gruppo di scambisti? C’è nell'aria una tensione collettiva che sembra fare il verso alle tante frustrazioni private. Il tutto si infiltra come una perdita dietro un muro, sgocciolando tra i respiri e i silenzi e il casino gonfio tutt'intorno. Si respira un’elettricità strana quando la rabbia repressa, indicibile, si manifesta in questi piccoli sfiati di nervosismo.
La tensione e il fastidio di Laura non mi turbano più da anni. Ora penso con un certo grado di convinzione che potrei far saltare tutto, magari allungando esplicitamente un piede verso la caviglia scoperta di lei che sporge dal lato del tavolino e godermi gli effetti imprevisti di quel gesto. Sarebbe sicuramente un buon diversivo. “Per me è uguale”, rispondo, “tu bevi ancora qualcosa?”. Laura si irrigidisce. “Be’, sai, è da quaranta minuti che vi aspettiamo”. Devo essere suonato provocatorio. “Non essere permalosa, era solo una domanda. Magari mi sai consigliare qualcosa, avendo già fatto esperienza”.
Lei mi guarda, sa di essere al centro del nostro screzio. Ricambio lo sguardo e sorrido. Laura percepisce tutto, mentre Marco si ostina a non prendere parte alla situazione, continuando ad estraniarsi tra i tavoli, le luci, il movimento diffuso del locale, le cameriere solerti e imbronciate.
“Tu almeno hai le idee chiare?”, chiedo a Marco.
Lui si gira ed è come se d’un tratto riacquistasse la sua corporeità, incarnandosi su quella poltroncina scomoda e rispondendomi secco “prendo quello che prende Marta”.
Lei, Marta, ora è definitivamente al centro dell’attenzione. Laura la accusa di essersi scopata suo marito, Marco le riversa addosso la responsabilità di dover far funzionare una serata inutile tra le tante, io la guardo sorridendo, tenendole gli occhi incollati addosso in cerca di una risposta, di un oracolo. Lei invece abbassa i suoi, che luccicano acquosi nella penombra stagnante del locale. Non ne può più. Anche io ne ho abbastanza.
Mi alzo. Mi guardano. Prendo la mano di Marta: “mi concedi un ballo?”. Laura diventa viola, Marco mi guarda incredulo, pare divertito ma percepisco un primo fremito di avversione. “Ma che dici? Non sai ballare, tu”. Faccio forza e lei si lascia sollevare, guardando i due al tavolo come per trovare in loro una giustificazione, una possibile strada da percorrere con il loro muto consenso. La trascino via e la porto in fondo al locale, dove poche coppie - gente più matura di noi - stanno muovendosi al ritmo di musica. La stringo cingendole i fianchi. Voglio farle sentire il mio umore. “Ora potrei”, le sussurro all'orecchio. “Ma che dici?”, fa lei guardando verso il nostro tavolino dissimulando tutto il suo imbarazzo. Glielo sento scorrere sotto pelle, l’imbarazzo. “Dico che ora ti prenderei qui, davanti a tutti”. Lo farei davvero se solo me lo chiedesse. Basterebbe anche un leggero aumento della pressione con cui si appoggia incerta alle mie spalle. “Stai facendo il coglione, finiscila. Mi metti in imbarazzo così”. Continua a guardare al tavolo sorridendo, come se stessimo scherzando di qualche battuta come due vecchi amici. La stringo più forte e le sussurro ancora all'orecchio: “andiamo da qualche parte, voglio te soltanto”. Lei si scosta di scatto, lasciandomi solo, eccitato e impotente, tra le altre coppie in movimento. Marta è ferma, immobile, mi guarda. Esprime così tante cose assieme che pare congelata, sembra una statua di sale. Con la coda dell’occhio scorgo Laura mentre si alza ed esce. Marco si decide a smuovere quella sua posa pigra ed ecco che inizia a venirci lentamente incontro, senza però dar l’impressione di avere un vero motivo per portare un passo davanti all'altro. Marta mi guarda ancora, ma ora lo fa con intensità. Quell'intensità mi gela il sangue nelle vene. Rimango sbigottito di fronte al suo muto giudizio, al suo disprezzo, alla sua condanna senza appello, alla sua decisione che non necessita di parole. Ho solo un unico pensiero sconnesso e ossessivo in testa, anche lui raggelato, incastrato come un loop su un nastro magnetico danneggiato. Più gira nella testa più si fa labile e impreciso. “Ora potrei... Ora potr i... Or p tr i... Or p t i”.
Poi perdo anche quell'ultimo rimasuglio e lei non mi guarda più.
“È tardi, ora. Troppo tardi. Lo è sempre stato in fondo”, dice. E fa quello che avrei dovuto fare io molto prima. Marta esce dal Bristol scartando suo marito che, sorpreso a metà strada, si irrigidisce senza più sapere come dare un seguito alla sua ormai inutile avanzata. Non sapendo se continuare o arretrare si blocca tra i tavolini. Anche io sono fermo. Lo guardo. Nei suoi occhi galleggianti leggo il riflesso speculare di una consapevolezza che inizia a farsi strada, materializzandosi nei miasmi dei commenti e dei risolini tutto intorno: da qui non si torna più indietro. Nella manciata di secondi in cui tutto questo accade penso che a volte la cosa migliore è prendersi del tempo. Mi lascio cadere su uno sgabello a poca distanza dal bancone del bar. Chiedo finalmente un drink, uno qualsiasi. Poi lo guardo ancora, Marco. Mi sembra che stia dissolvendosi, sfumando come uno spettro.
Sorrido. Ora sì, ora potrei.